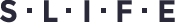C’è un filo che attraversa tutta la sua traiettoria: non l’idea della “vocazione” come folgorazione, ma la costruzione lenta di una cifra che si riconosce mentre si lavora. Prima ancora di diventare mestiere, il design è stato un gesto quotidiano — il disegno come primo alfabeto, come spazio per dare forma a emozioni e pensieri. Da lì, il passaggio non è mai stato una rottura: formazione artistica, Politecnico, e quell’attrito fertile tra moda e progetto industriale, tra desiderio e disciplina.
L’abbiamo intervistata per entrare dentro questo punto di equilibrio: come si difende un immaginario autoriale quando incontra tempi, costi, vincoli e filiera; che cosa rende una texture “struttura” e non semplice decorazione; e come si resta fedeli a un metodo — e insieme vivi — quando l’attenzione cresce, le aspettative aumentano e la coerenza rischia di trasformarsi in maniera.
Intervista a Elena Salmistraro Design Studio

Classe 1983, la designer e artista Elena Salmistraro vive e lavora a Milano e nel 2009 ha fondato il suo studio insieme all’architetto Angelo Stoli, dopo la formazione al Politecnico di Milano. Selezionata dalla redazione di Archi&Interiors tra i 50 product designer italiani contemporanei da tenere d’occhio nel 2026, in questa intervista ripercorre il suo percorso e mette a fuoco i cardini del suo metodo: il segno come struttura, la materia come racconto, l’emozione come funzione dell’oggetto.
Ciao Elena, raccontaci di te. Ricordi il punto preciso in cui hai capito che il design sarebbe stato il tuo mestiere — non solo un interesse? Dov’eri, che cosa stavi facendo, e che cosa ti ha fatto dire: “questa è la mia strada”?
La mia passione per l’arte e il design nasce molto presto, in modo spontaneo, quasi inevitabile. Ho sempre disegnato. Da bambina ero piuttosto timida e il disegno è stato il mio primo vero linguaggio, il mezzo più immediato per dare forma a emozioni e pensieri. Non era una scelta consapevole, ma un gesto naturale e quotidiano, qualcosa che sentivo semplicemente di dover fare. Con il tempo quel gesto si è trasformato prima in una passione profonda e poi in una decisione, tanto da portarmi a frequentare il liceo artistico.
Il passo successivo è stato il Politecnico, dove mi sono laureata in fashion design. È stata un’esperienza importante e molto formativa, ma andando avanti ho iniziato ad avvertire una distanza crescente dai ritmi e dalle dinamiche del sistema moda. Parallelamente, approfondendo sempre di più il mondo del prodotto, è emersa con chiarezza l’esigenza di ripartire. Ho capito che il product design era il territorio in cui potevano convivere in modo naturale tutte le mie competenze e sensibilità, senza forzature.
Non c’è stato un momento preciso, una rivelazione improvvisa in cui ho pensato “questa è la mia strada”. È stato piuttosto un percorso graduale, fatto di passaggi coerenti tra loro che, guardati oggi, seguono tutti lo stesso filo logico. Il design ha smesso di essere solo un interesse ed è diventato un mestiere mentre lo facevo.
La formazione a Brera ti ha dato un’attitudine molto forte all’immagine e al segno. Che cosa ti ha insegnato davvero l’arte, in termini di disciplina e di sguardo, che oggi riconosci ancora nel tuo modo di progettare?

La formazione a Brera mi ha lasciato in eredità molto più di una competenza tecnica sull’immagine o sul segno. Mi ha insegnato, prima di tutto, un modo di guardare il mondo, ancora prima che un modo di intervenire su di esso. L’arte mi ha abituata a pensare il processo come qualcosa di vivo e mobile, mai davvero lineare, capace di cambiare direzione in base a ciò che il progetto attiva, suggerisce o rivela lungo il percorso.
Non ho mai lavorato seguendo un metodo rigido o prestabilito. A volte il punto di partenza è un’esigenza funzionale molto concreta, quasi brutale nella sua chiarezza, che col tempo si apre ad altri livelli di lettura, ad altri immaginari, fino a costruire una struttura più complessa e stratificata. In altri casi, invece, è l’immagine a prendere il sopravvento. La forma diventa uno strumento di indagine, un campo di esplorazione attraverso cui capire fin dove il progetto può spingersi.
L’arte mi ha insegnato soprattutto una disciplina della sperimentazione. Non nel senso romantico del gesto libero a ogni costo, ma come esercizio continuo di tentativi, errori, deviazioni. Ho imparato a diffidare dei percorsi troppo sicuri e a preferire il rischio dell’errore alla comodità della ripetizione. La ripetizione rassicura, ma spesso conduce all’omologazione, ed è proprio da lì che sento il bisogno di prendere le distanze.
Anche il mio sguardo sul mondo nasce da questa attitudine. L’ispirazione arriva da ciò che mi circonda, dalla vita quotidiana, da quello che leggo, ascolto, osservo, non esclusivamente dal design. Questo alimenta un’idea molto forte di autorialità. Ogni progetto, ogni oggetto, porta con sé qualcosa di chi lo ha immaginato. Una traccia silenziosa, magari invisibile, ma tenace.
Al Politecnico di Milano attraversi Fashion Design (2003) e poi Industrial Design (2008). Qual è l’elemento decisivo che ti sei portata dietro da questo percorso “doppio” e che oggi consideri parte strutturale della tua grammatica?
Quel percorso “doppio” mi ha lasciato in eredità un modo di pensare il progetto come un territorio elastico, mai davvero rigido. La moda mi ha abituata a muovermi dentro una temporalità veloce, quasi nervosa, in cui il progetto è sempre in relazione con qualcuno che lo indossa, lo attraversa, lo vive e lo consuma emotivamente prima ancora che fisicamente. C’è un’attenzione continua all’utente, al desiderio e all’immaginario, ma anche alla consapevolezza che un oggetto o una forma possano invecchiare, cambiare significato, essere superati.
Il design industriale, al contrario, mi ha insegnato la disciplina. La necessità di dare alle cose una struttura interna, di costruire sistemi coerenti, di confrontarsi con logiche produttive, tecniche e funzionali che non sono negoziabili. È un ambito meno indulgente e più lento, in cui le decisioni devono reggere nel tempo e dove l’oggetto non può permettersi di essere soltanto espressivo.
Tenere insieme questi due approcci ha definito la mia grammatica progettuale. Da una parte c’è la libertà, la stratificazione, la possibilità di lavorare su più livelli di lettura, tipica della moda e dell’arte. Dall’altra c’è una base solida, quasi invisibile, fatta di regole, proporzioni e struttura. È proprio quel punto di contatto tra i vari mondi che mi interessa, lì dove l’uno mette in crisi l’altro. In quello spazio il progetto smette di essere solo “corretto” o solo “seduttivo” e diventa qualcosa di più complesso, ambiguo e, per me, più vero.
Nel 2009 fondi lo studio con l’architetto Angelo Stoli, compagno di vita e di lavoro. Che cosa vi siete dati, professionalmente, in questi anni? E come è cambiato il vostro processo, dalla prima idea al prodotto finito?

Ci completiamo sia sul piano professionale sia su quello umano. Condividiamo gusti e sensibilità progettuali, ma il nostro approccio al lavoro è molto diverso, io mi muovo in modo più analogico, intuitivo e immaginativo, mentre Angelo è digitale, razionale e orientato alla concretezza. Questa differenza, non è un limite anzi, è diventata la forza del nostro processo creativo, perché io sogno e abbozzo le prime idee, lui le trasforma in progetti realizzabili, traducendo visioni in oggetti concreti.
Fin dall’inizio abbiamo definito i ruoli all’interno dello studio in base alle nostre competenze e inclinazioni naturali. Le discussioni e gli scambi di opinione ovviamente ci sono, ma sempre in un clima di ascolto reciproco e collaborazione, dove ciascuno porta il proprio contributo senza sovrapporsi all’altro. Con il tempo, le responsabilità sono cresciute e ogni progetto richiede più attenzione agli aspetti organizzativi e tecnici, ma sempre rispettando le inclinazioni di ciascuno.
Il cuore del nostro lavoro, però, non è cambiato, resta quella dinamica tra sogno e concretezza, intuizione e metodo.
Nel tuo lavoro c’è sempre un equilibrio tra immaginario autoriale e produzione seriale. Qual è il patto minimo che un’azienda deve accettare perché il tuo linguaggio non venga “normalizzato” lungo la filiera?
Non credo che esista un patto minimo formale, quanto piuttosto una vera e propria affinità di intenti e visioni. Quando un’azienda entra in contatto con me, o io con lei, lo facciamo perché esiste una stima reciproca e una sintonia sui valori e sull’approccio creativo. Questo è l’elemento fondamentale per far sì che un progetto riesca.
È chiaro che, a seconda della scala produttiva e della tipologia di prodotto, una certa normalizzazione è inevitabile, i materiali, i processi industriali, i costi e i tempi impongono dei limiti concreti. La differenza sta nel modo in cui questi limiti vengono affrontati, perchè quando c’è una vera collaborazione, ogni scelta è condivisa e valutata insieme, così da mantenere e valorizzare il linguaggio dell’azienda e la cifra autoriale del designer. Non si tratta di imposizioni e rigidità, ma di creare piuttosto un equilibrio consapevole tra il progetto creativo e le esigenze produttive.
Il mio approccio è sempre collaborativo, mi piace dire che lavoro “con” l’azienda, non “per”. Lo scambio, il dialogo continuo, la condivisione e soprattutto l’affinità umana sono prerequisiti imprescindibili. Senza questa connessione di valori e sensibilità, io rischierei di appiattire il mio linguaggio, al contrario però si rischierebbe di snaturare l’essenza dell’azienda.
Hai detto che l’emozione è una funzione dell’oggetto. Quando arrivi su un brief reale — costi, tempi, vincoli, produzione — come traduci questa idea in scelte misurabili? Che cosa non deve mai andare perso?

Quando parlo di emozione come funzione dell’oggetto, non mi riferisco a un elemento decorativo o superficiale, ma a qualcosa di più profondo, perché l’oggetto deve saper comunicare, evocare sensazioni e creare connessioni, il design è soprattutto trasmissione di cultura. È questo che lo rende riconoscibile, memorabile e capace di emergere anche all’interno di un contesto industriale.
Quando ci si confronta con un brief reale, ovviamente entrano in gioco i vincoli concreti dei costi, tempi, materiali. Questo diventa il terreno su cui si misura la progettualità e dove occorre capire cosa dell’oggetto può essere adattato senza compromettere il suo nucleo emotivo e cosa, invece, costituisce la sua identità. Si può, per esempio, semplificare una giunzione o modificare un dettaglio per agevolare la produzione, ma non si possono alterare forma, colore o l’idea centrale.
Ciò che non deve mai andare perso è il concetto, la teoria che guida le scelte, il messaggio che l’oggetto deve trasmettere, il senso che orienta ogni decisione. Senza questo, anche un oggetto tecnicamente impeccabile rischia di risultare freddo, anonimo, privo di significato.
Texture e tridimensionalità sono centrali nel tuo linguaggio. Qual è, per te, la differenza netta tra progettare una superficie e “decorarla”? E qual è l’errore più frequente che vedi oggi quando si lavora con pattern e texture?
La differenza tra progettare una superficie e decorarla non è solo teorica ma riguarda l’intero approccio al materiale, alla forma e all’esperienza dell’utente.
Quando si progetta una superficie, questa è parte integrante del progetto stesso. Non è un elemento aggiunto, ma il risultato di un pensiero che considera profondità, curvature, geometrie e ritmo visivo in funzione di uno scopo preciso. Ogni dettaglio ha un peso che influenza la tattilità, la luce, l’ombra e l’interazione con lo spazio circostante.
Decorare, invece, è un gesto più narrativo, interpretativo. Si interviene su qualcosa che già esiste, quindi l’atto creativo si sviluppa come un dialogo più che come una costruzione. La decorazione può sorprendere, enfatizzare, raccontare, ma non ridefinisce la struttura di base. È un’aggiunta, una lettura, non una creazione ex novo.
Oggi l’errore più comune è sottovalutare la decorazione, considerandola secondaria. Questo porta a interventi superficiali, privi di riflessione sul senso, sul valore estetico e sull’esperienza tattile. Trascurare la forza della decorazione significa perdere opportunità, perché non esistono gerarchie tra progettare e decorare, esistono solo approcci consapevoli o superficiali. Penso ai musei di arte decorativa, dove è facile capire quanto sia potente il racconto di superfici pensate, capaci di emozionare e di resistere al tempo.
Hai raccontato che il 2017, al Salone del Mobile di Milano, è stato un momento di svolta. Che cosa è cambiato davvero da lì in avanti: il tipo di opportunità, il livello di pressione, il tuo metodo, o la consapevolezza del tuo ruolo?

Il 2017 non ha rappresentato tanto un cambio di direzione quanto un cambio di assetto. Prima il lavoro era un inseguimento continuo, cercare contatti, proporre visioni, spiegare perché un certo linguaggio fosse sensato. Con il tempo il dialogo si è riequilibrato. Le aziende arrivavano già con un’idea abbastanza chiara di chi fossi e di cosa cercassero nel mio lavoro. Questo ha reso le occasioni più stimolanti.
Di pari passo è aumentata la pressione, perché ogni scelta diventa più visibile, più osservata, più esposta. È uno stress sottile, che non riguarda solo le scadenze ma la continuità, il tentativo di mantenere una coerenza senza farla scivolare nella maniera.
Il metodo, invece, è rimasto uguale per necessità, anzi ho capito quanto fosse importante proteggerlo. I riconoscimenti non mi hanno spinto a cambiarlo, semmai mi hanno dato gli strumenti per difenderlo meglio, per imparare a dire dei no più consapevoli e per evitare compromessi che lo avrebbero svuotato di senso.
Infine la consapevolezza del mio ruolo è un tema che preferisco tenere a distanza. L’idea stessa di ruolo implica una funzione, una posizione definita, una maschera. Io non lavoro per occupare uno spazio nel sistema. Quando ci si identifica troppo con un ruolo, si rischia di lavorare per mantenerlo invece di seguire un’urgenza reale. E a quel punto, almeno per me, il lavoro smette di essere vivo.
Dopo quel passaggio, tra premi e attenzione internazionale, come si fa a restare fedeli alla propria autenticità? Che cosa fai, concretamente, per continuare a evolvere senza perdere coerenza?
Resto fedele a me stessa scegliendo una strada semplice, e tutt’altro che strategica, continuo a fare ciò che mi diverte davvero.
Disegnare oggetti, anche se è un lavoro serio, per me rimane prima di tutto un gioco meraviglioso. Un gioco serio, come il titolo dell’installazione che ho presentato a Francoforte durante Ambiente. In quelle due parole c’è già tutta la tensione che mi interessa mantenere viva.
Il divertimento è essenziale per crescere e per spingersi oltre ciò che si conosce già. Lo vedo chiaramente anche con i miei figli, quando provo a insegnare qualcosa imponendo regole ed aspettative, il risultato è spesso modesto. Quando invece tutto passa dal gioco, dalla curiosità e dalla libertà di sbagliare, il potenziale si moltiplica. Nel mio lavoro è esattamente la stessa cosa.
Il gioco ha anche un altro potere, abbassa la tensione. Premi, attenzioni e aspettative, se presi troppo sul serio, rischiano di trasformarsi in una gabbia. Continuare a giocare, invece, li rende più leggeri e mi permette di restare concentrata su ciò che conta davvero, quindi il mio linguaggio e la sua coerenza.
Dal 2017 partecipi anche a contesti istituzionali e internazionali come l’Italian Design Day, in qualità di World Ambassador of Italian Design. Che cosa significa, per te, rappresentare il design italiano fuori dall’Italia? Che cosa senti di dover portare: estetica, manifattura, cultura, o un modo di pensare?

Rappresentare il design italiano all’estero è sempre una grande responsabilità, ma prima ancora una grande gioia. L’Italian Design Day è ogni volta un’occasione preziosa, perché cambia ogni anno e ci invita, come Ambassador, a raccontare attraverso il nostro percorso cosa rende il design italiano riconoscibile e unico nel mondo. Ed è inevitabile che entrino in gioco tutte le caratteristiche che hai citato, perché il design italiano non è mai riducibile a un solo aspetto. È estetica e manifattura, ma anche cultura, pensiero, intuizione e stratificazione. È plurale, è capace di tenere insieme il sapere artigianale e l’innovazione.
Inoltre per me è sempre anche un momento di crescita personale. Raccontare il proprio lavoro all’estero significa metterlo in discussione, guardarlo da una certa distanza e scoprire affinità con altri paesi e altri modi di pensare. È uno scambio, non una semplice vetrina, e ogni volta si torna con uno sguardo un po’ più ampio e qualche certezza in meno, segnale che è qualcosa di buono.
Hai lavorato con aziende globali di notevole importanza — Disney, Apple, Vitra, Nike, Ikea, Huawei, Microsoft, Moooi — e con aziende italiane dal DNA fortissimo — Alessi, Cappellini, Florim/Cedit, Natuzzi, Bosa, De Castelli, cc-tapis, Lavazza, Driade, Technogym, Ceramica Flaminia, Alcantara, tra le altre. Che cosa cambia, per te, quando cambia la “scala” dell’azienda? E cosa resta invariato nel tuo modo di prendere decisioni?
Per me, idealmente, non cambia nulla. O almeno ci provo.
La vera differenza tra una multinazionale e un’azienda più piccola non sta nella visione, ma nella complessità del sistema. Si passa da uno o due interlocutori a dieci, a volte venti. Ogni decisione diventa più lenta, più mediata, rinchiusa in una rete di passaggi e burocrazia. È una questione strutturale, non creativa.
Con il tempo ho però notato una costante chiara, più un’azienda cresce, più la sperimentazione tende a ridursi. Il coraggio sembra spesso inversamente proporzionale alla scala, ma non per mancanza di talento o di intelligenza, ma perché il rischio si diluisce in una catena di responsabilità molto lunga.
Personalmente cerco di non cambiare mai il mio modo di prendere decisioni. Non mi lascio condizionare dal “peso” del nome con cui sto lavorando. Un progetto resta un progetto, e va affrontato con la stessa serietà, curiosità e onestà intellettuale, che si tratti di una grande corporation o di un’azienda familiare. Anche perché, il progetto rimane sempre un lavoro di squadra e ovviamente cambiano i tempi, cambiano le modalità, cambiano i processi. Ma il risultato finale resta l’unica cosa che conta davvero.
Se dovessi lasciare a un giovane designer una sola, che cosa gli diresti per evitare gli errori più comuni e costruire un linguaggio solido?

Gli consiglierei di non rincorrere ciò che fanno gli altri o quello che è considerato ‘di moda’. La cosa davvero importante è coltivare una propria voce, un linguaggio personale che rifletta chi è e ciò che pensa. Alla fine, l’unicità vale molto più di qualsiasi regola o influenza esterna.
Se dovessi scegliere un solo colore che ti rappresenta oggi, quale sarebbe? E che cosa ti permette di dire quel colore che gli altri non dicono?
Oggi mi sento come un violetto desaturato, ma intenso. Non quel viola acceso che cattura subito lo sguardo, ma un tono più riflessivo, che resta senza bisogno di urlare. Un colore che porta creatività, suggerisce idee, ma senza fretta, e con calma interiore.
Un colore che a differenza di altri colori sa dire che la forza non deve sempre mostrarsi, che l’energia può essere silenziosa, e che la bellezza nasce dalla pazienza e dalla profondità.
Qual è l’oggetto che non hai progettato tu, ma che avresti voluto firmare? E, invece, di quale tuo progetto vai più fiera e perché?
Un oggetto che avrei amato firmare è il lampadario Vertigo di Constance Guisset. Lo trovo straordinario, infatti ne ho comprati due, uno per il mio studio e uno per la casa in montagna, perché ha la capacità di trasformare lo spazio con una leggerezza e una poesia davvero rare. L’idea alla base è semplice, ma l’effetto che produce è enorme, riesce ad emozionare e catturare lo sguardo immediatamente.

Tra i miei progetti, invece, quello di cui sono più orgogliosa in questo momento è ovviamente l’ultimo nato, quindi la collezione di vasi Succulentia disegnata per Bosa. Una collezione dove ho potuto approfondire il rapporto tra natura, forma e colore, disegnando oggetti che non sono solo funzionali.

Guardando ai prossimi anni: di che cosa ha davvero bisogno il design, secondo te? E che cosa, invece, dovremmo avere il coraggio di lasciare alle spalle?
Il design nei prossimi anni ha bisogno di riscoprire sé stesso, di ritrovare il coraggio di sperimentare senza paura e la leggerezza di affrontare le sfide con allegria. Ha bisogno di liberarsi di quella seriosità e di quello snobbismo inutile che spesso lo rendono distante, autoreferenziale e chiuso. Serve un design che sappia giocare, emozionare e parlare alle persone senza filtri, che sappia osare senza prendersi troppo sul serio, e che torni a essere uno spazio di scoperta e di gioia.
Leave a comment